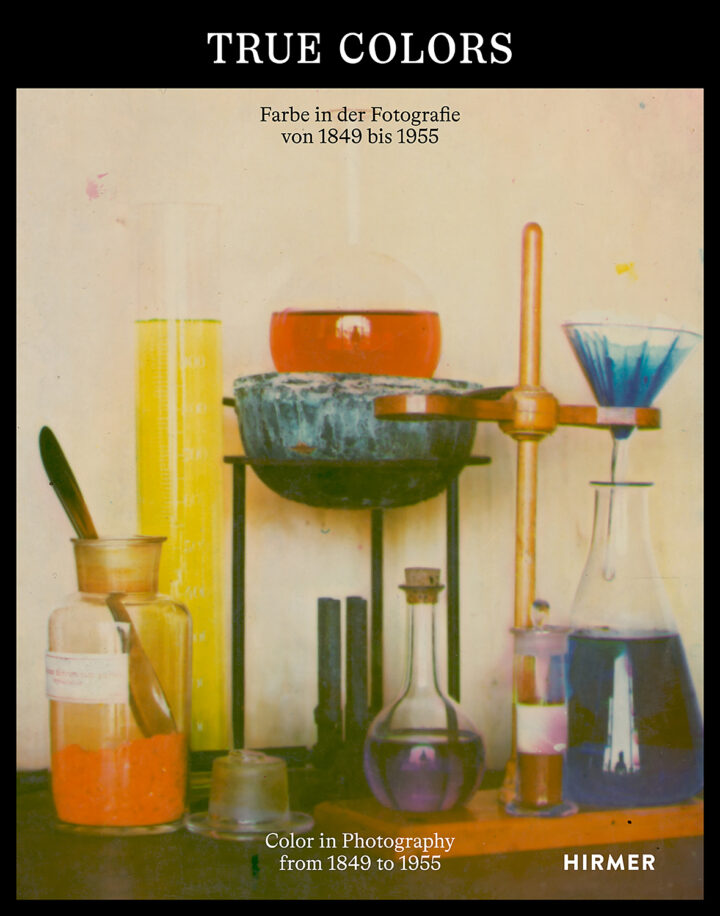Era l’orfano che si è inventato da solo. Per quattordici anni Olivier Rousteing ha trasformato la maison Balmain in uno spettacolo pop – un periodo sospeso tra genio, megalomania e autoidolatria digitale. Ora si chiude un’era in cui lo splendore è stato confuso con il significato.
Il decennio d’oro
Quando il prodigio della moda Olivier Rousteing, nel 2011, assunse la direzione della maison francese Balmain a soli venticinque anni, la casa era già un relitto di tempi passati: elegante, ma stanca. Il giovane stilista portò energia, rumore e se stesso. Un designer nero al centro dell’haute couture parigina – era più di un nuovo stile, era un segnale. Rousteing possedeva un senso istintivo della forma e della proporzione che stabilizzò Balmain sul piano artigianale ed economico. Le sue prime giacche rigidamente costruite e i richiami all’archivio di Pierre Balmain rivelavano sostanza – ma lui capì che il potere nella moda si era spostato: dal mestiere alla visibilità. Dove un tempo regnava il silenzio, ora esplodevano segnali abbaglianti. La sua scena non era più l’atelier, ma Instagram, e lui stesso divenne il protagonista del nuovo dramma della moda.
Il culto della visibilità
Con la “Balmain Army” Rousteing creò una rete di volti celebri e di portata globale che tradusse la moda in pura esposizione. Kim Kardashian, Rihanna e Beyoncé indossavano le sue creazioni e lo resero la star del suo stesso marchio. Non mise in scena soltanto abiti, ma anche appartenenza: chi indossava Balmain apparteneva al suo universo di splendore e potere. La sua moda era come un’armatura: metallica, lucente, una dichiarazione di controllo. Rousteing celebrò la “donna potente”: impeccabile, inavvicinabile, sempre perfettamente illuminata. Predicava forza per nascondere la vulnerabilità. Ma dietro la retorica dell’autostima si celava un ideale corporeo che chiedeva durezza più che libertà. Mise in scena la diversità, ma raramente l’uguaglianza – il suo ideale rimase la donna perfetta e infrangibile. Ogni cucitura era un’affermazione, ogni abito una dichiarazione: “Esisto perché mi vedi.” Rese il lusso compatibile con l’era del selfie e trasformò l’esclusività in presenza continua. Ma più la luce diventava intensa, più la sua brillantezza si appiattiva. Rousteing colse lo spirito di un’epoca che confuse la bellezza con il potere e fece dello splendore dell’oro la propria religione.
Lo specchio come palcoscenico
Rousteing non era né sarto né artigiano, ma il regista del proprio mito. Mentre altri drappeggiavano tessuti, lui coreografava l’attenzione. Ogni collezione era al tempo stesso specchio e palcoscenico – un atto di continua auto-invenzione. Con gli anni, le sue apparizioni divennero più grandi delle sue creazioni e la sua presenza finì per dominare il marchio. Balmain divenne la scenografia per l’uomo al centro della scena. Parlava di diversità, ma intendeva soprattutto la visibilità – la propria. Il messaggio era: “Se vedi me, vedi il progresso.” Ma un progresso che applaude solo se stesso si esaurisce in fretta. Con il tempo, la ribellione si trasformò in routine e il ribelle in un uomo spinto dal proprio meccanismo. Rousteing oscillava tra emozione e calcolo – uno stratega che dirigeva con precisione la propria autoesaltazione. Cercava forse amore, ma trovò soprattutto ammirazione, che chiedeva costantemente nuovi riflettori.
Il fuoco e la facciata
Nell’estate del 2021 un’esplosione nell’appartamento parigino di Rousteing incendiò una stanza. Subì gravi ustioni al torace, alle braccia e alle mani. Per molto tempo rimase in silenzio. Mentre il suo corpo guariva, costruì una nuova facciata. Colletti alti, pelle coperta – il dolore restava nascosto, perché non si adattava all’immagine. Un anno dopo mostrò le cicatrici su Instagram: perfettamente illuminate e cariche di pathos. Anche la ferita divenne parte della sua narrazione. Rousteing trasformò il dolore in motivo e il trauma in ornamento. Da allora la sua moda parlò di forza, ma respirava paura. Le bende che portò in passerella sembravano meno un conforto che un travestimento. Sopravvisse e trasformò la sopravvivenza in stile. Ma così perse quell’autenticità che nasce solo dove finisce il controllo.
La caduta silenziosa
Sotto la sua guida, Balmain divenne l’eco della propria età dell’oro. Le collezioni giravano in tondo, mostrando volti e pose familiari – cambiava solo la data. Rousteing parlava di nuovi inizi, ma ogni look ricordava il precedente. Ciò che un tempo era provocazione divenne routine. Il marchio brillava, ma non ardeva più. Anche i clienti più fedeli finirono per desiderare il silenzio. Non volevano più spettacoli, ma artigianato e misura. Ma anche la “misura” è una forma di messa in scena – una che forse a Rousteing rimase estranea. Continuò, come sempre, a essere il più rumoroso nella stanza. Parlava di autenticità e diversità, ma creò un mondo di luci di scena e riflessi che rimandavano solo la sua immagine. Balmain rimase stabile sul piano economico, ma esteticamente esausta. Mayhoola, il proprietario qatariota della casa, lo lasciò fare finché la sua ripetizione non divenne impossibile da ignorare e mise a rischio il successo del marchio. Poi arrivò il cambio: il nuovo CEO Matteo Sgarbossa chiese un ritmo diverso e una “riorganizzazione creativa”. Dietro questa formula si celava un addio come se ne vedono spesso nel settore: cortese nelle parole, ma da tempo deciso.
L’eredità del vuoto
Olivier Rousteing lascia una maison splendente che non proietta più ombre. Ha salvato Balmain, l’ha modernizzata e riempita di nuova vita – ma al tempo stesso l’ha svuotata. Il suo più grande merito fu aprire la moda a un pubblico nuovo e giovane. La sua più grande sconfitta fu ridurla a pura superficie. Portò la diversità in passerella, ma spesso solo come elemento decorativo. Parlò di inclusione, ma restò uno strumento di stile privo di rischio. Ciò che era iniziato come rivoluzione finì nella routine di un uomo convinto della propria indispensabilità. La sua estetica, un tempo un grido, divenne un algoritmo calcolato e vuoto. Anche il lusso che incarnò con tanta eccessività perse sotto di lui la propria aura esclusiva. Se questo addio sia un fallimento o semplicemente la fine di un ciclo, resta aperto. Le sue parole di commiato suonarono insolitamente sobrie: “Sono profondamente orgoglioso di tutto ciò che ho realizzato e infinitamente grato al mio straordinario team.” Parole accuratamente scelte, prive di collera o sfida. Rousteing è stato la figura perfetta per un’epoca in cui la visibilità contava più del significato – un’era soffocata dal proprio splendore.
Dopo la luce
Nel suo addio a Balmain, Rousteing si trovò ancora una volta esattamente dove aveva sempre voluto essere: al centro dell’attenzione. Ma anche la stella più luminosa brilla solo finché non si consuma. Aveva controllato tutto – la propria immagine, il proprio corpo – eppure dietro tutto quel controllo non restava che superficie. Per lui la moda non è mai stata tessuto, ma specchio. Ora quello specchio riflette solo se stesso, accecato dal proprio bagliore. Il fumo si è dissolto, ma la polvere d’oro aleggia ancora nell’aria. Rousteing andrà avanti, da qualche parte, in qualche modo – non conosce altra forma di sopravvivenza se non la visibilità. Nella moda cercava ciò che la vita gli aveva negato: appartenenza. Ma la moda non è un luogo di terapia, bensì di illusione. Trasforma il dolore in superficie – e in questo, era un maestro.